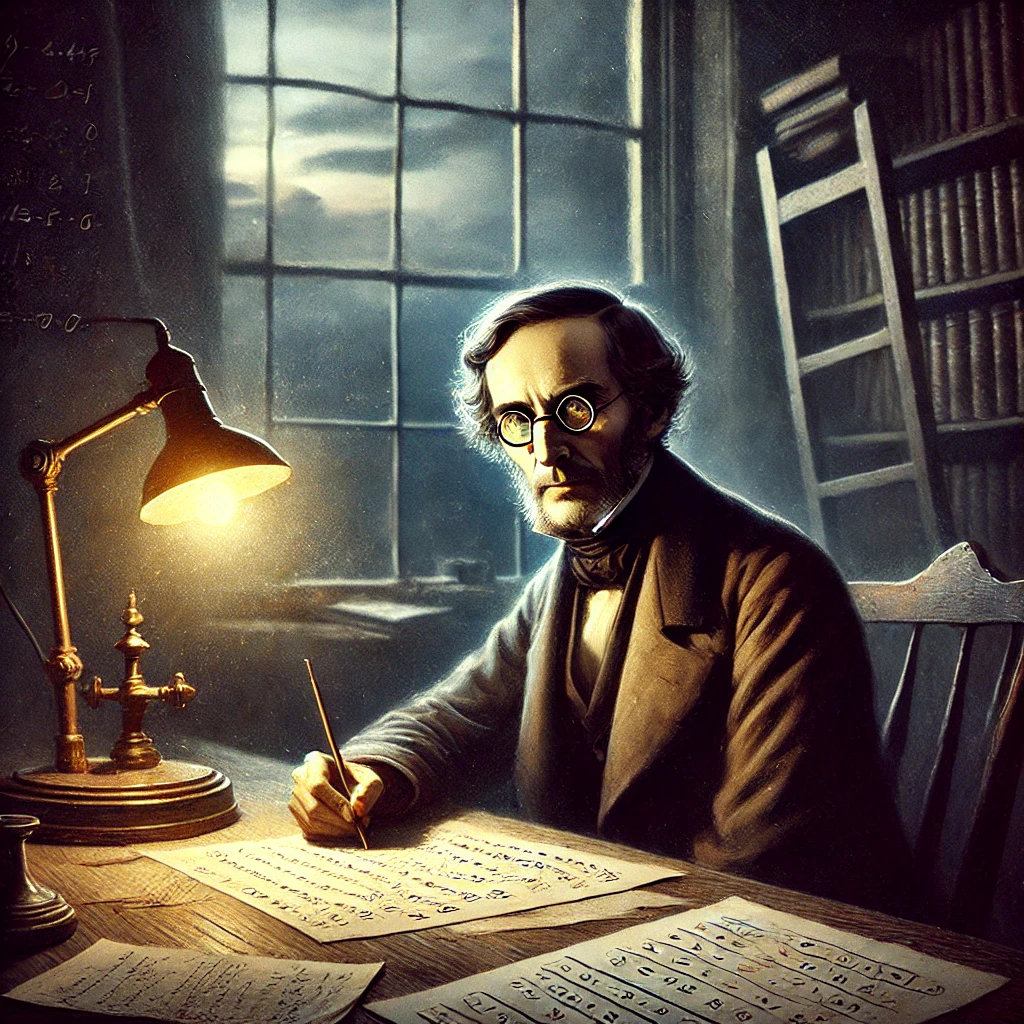Nel 1847, George Boole sedeva in una stanza silenziosa a Lincoln, in Inghilterra, con una lampada che gettava ombre tremanti sui suoi fogli pieni di simboli. Non era un uomo da clamori: magro, con barba rada e occhiali che gli scivolavano sul naso, sembrava un insegnante di paese più che un rivoluzionario. Nato nel 1815 in una famiglia modesta, Boole era cresciuto tra libri presi in prestito e un padre calzolaio che gli insegnava a costruire lenti. Ma quel giorno, scribacchiando equazioni, stava cambiando la logica: non più solo parole, ma numeri e segni – un’algebra del pensiero. Nello stesso secolo, matematici come Lobachevsky e Riemann piegavano lo spazio, inventando geometrie non euclidee che sfidavano Euclide e il senso comune. La logica dell’Ottocento non era un gioco astratto: era una chiave, un modo nuovo di vedere la mente e l’universo, un ponte tra la scienza e l’infinito.
L’Europa del XIX secolo era un mosaico di scoperte. La Rivoluzione Industriale ruggiva, la fisica illuminava il buio con onde e campi, e la filosofia – da Hegel a Mill – cercava ordine nel caos. Ma la logica, con le sue regole polverose, sembrava ferma al Medioevo: Aristotele dominava, con sillogismi che suonavano come litanie. Boole arrivò in questo mondo con una mente curiosa. Autodidatta, aveva imparato greco e latino da solo, aprendo una scuola a 19 anni per sfamare la famiglia. “Il pensiero è una macchina,” pensava, con occhi che brillavano dietro le lenti. Nel Leggi del pensiero (1854), trasformò la logica in matematica: “vero” era 1, “falso” 0, e operazioni come “e” o “o” diventavano simboli. Immagina una disputa: “Tutti gli uomini sono mortali” si riduce a un’equazione. Era semplice, ma profondo: la logica di Boole vive oggi nei computer, un’eco lontana di quella stanza silenziosa.
Intanto, lo spazio si piegava. Per secoli, Euclide aveva regnato: linee parallele non si incontrano, la somma degli angoli di un triangolo è 180 gradi. Ma nel 1829, Nikolaj Lobachevsky, a Kazan in Russia, guardava oltre. Nato nel 1792, figlio di una madre sola, era cresciuto tra steppe e libri, con una barba folta e una mente ribelle. “E se le parallele si incontrassero?” si chiese, con una penna che tremava di audacia. Nella sua geometria iperbolica, lo spazio si curvava: su una superficie come una sella, un triangolo aveva meno di 180 gradi. A Budapest, János Bolyai, un giovane con capelli arruffati e spada al fianco, arrivò alla stessa idea negli anni ’30, scrivendo al padre: “Ho creato un mondo nuovo.” Era un colpo: lo spazio non era piatto, poteva essere strano, alieno.
Bernhard Riemann, a Göttingen, portò tutto più lontano. Nel 1854, davanti a una sala di professori, un uomo timido con occhi chiari e voce incerta presentò la sua geometria. Nato nel 1826 in una Germania di villaggi e povertà, Riemann era un genio fragile: studiava Bibbia e matematica, con mani che tremavano per la fame. “Lo spazio può curvarsi in molti modi,” disse, con un tono che pesava ogni sillaba. Nella sua geometria differenziale, un triangolo su una sfera – come la Terra – aveva più di 180 gradi. Immagina una nave che naviga: segue una curva, non una linea retta, perché il mondo è tondo. Riemann morì giovane, nel 1866, a 39 anni, di tubercolosi, ma le sue idee volarono: Einstein le usò per la relatività, piegando lo spazio-tempo con la gravità.
Questi uomini vivevano tra carta e sogni. Boole, a Cork in Irlanda, insegnava tra aule fredde, con studenti che copiavano i suoi “1” e “0”. Lobachevsky, isolato in Russia, scriveva sotto lampade a olio, ignorato dai più. Riemann, a Göttingen, lavorava con un tavolo pieno di calcoli, tossendo mentre la luce svaniva. Non era facile: Boole morì nel 1864, a 49 anni, per un raffreddore preso sotto la pioggia; Lobachevsky nel 1856, a 63, cieco e dimenticato; Riemann fragile fino all’ultimo. Ma i loro laboratori erano la mente: provette di pensieri, alambicchi di simboli, esperimenti che non puzzavano di zolfo ma cambiavano il mondo.
La logica e le geometrie non euclidee scuotevano tutto. Boole dava un linguaggio alla scienza: “Pensare è calcolare,” diceva, e oggi ogni clic lo prova. Lobachevsky e Riemann aprivano universi: se lo spazio non era euclideo, cos’era reale? Filosofi come Kant, che vedevano lo spazio come intuizione fissa, barcollavano; fisici come Maxwell trovavano ispirazione. Nel 2025, li sentiamo: la logica di Boole è nei nostri chip, le curve di Riemann nei GPS. Pensiamo a un satellite: segue orbite non euclidee, un’eco di quei sogni. Ma non erano perfetti. Alcuni li trovarono astratti: “E la vita vera?” Altri persi: “Troppo lontano?” Per uno studente di oggi, sono una porta: ti mostrano che il pensiero piega il mondo. Immagina un codice: non è solo numeri, è un’Ottocento che respira ancora.